Una storia un po’ da riscrivere 10. “Maestra di vita”?
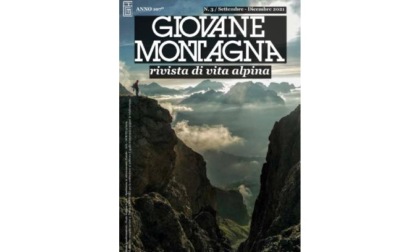
Una storia un po’ da riscrivere 10. “Maestra di vita”?
La montagna è ancora “maestra di vita”? Chi sono oggi i nemici dell’“alpinismo educatore”? Con chi ce l’avrebbero l’abbé Gorret, Dionisio Borra, Antonio Cojazzi, l’abbé Henry?
Verrebbe innanzitutto da pensare ai “cattivi maestri”, gli eroi protagonisti dell’alpinismo estremo, a quelle imprese dove la morte è in agguato a ogni passo, a quelle narrazione diffuse dai media con milioni di followers, pagine facebook, foto su instagram, sponsor commisurati al rischio. Verrebbe da pensare a quelle storie, indubbiamente avvincenti perché trasmettono il sapore del sangue, rielaborate in libri, riviste, film, documentari che occupano nell’immaginario collettivo lo spazio che un tempo spettava gli eroi dell’esplorazione.
Ma, sebbene sia quello un altro alpinismo, molto lontano dalla montagna “maestra di vita”, non è quello il vero nemico. C’è sempre stato, in tutte le attività umane, chi si è spinto “oltre il possibile”. E per fortuna. Se non ci fossero stati i visionari dell’esplorazione metà della terra non sarebbe ancora abitata e se qualcuno non avesse infranto i limiti del possibile saremmo ancora sugli alberi. Certo non definirei “educativo” il free solo di Honnold su El Capitain, e nessuno mi racconti che le invernali sugli Ottomila siano “amore per la montagna”, semmai una dipendenza una “droga”, come scrive esplicitamente Elisabeth Revol che un anno dopo la tragedia sul Nanga Parbat era già sulla vetta dell’Everest.
Non proporrei quegli esempi ai miei allievi e non vorrei mai che mio figlio li seguisse, ma se qualcuno, per ragioni che solo lui sa e che nessuno può permettersi di giudicare, vuole giocarsi la vita per fare l’impresa, libero di farlo. Non sarà forse il più utile dei sacrifici (“ho grande compassione per loro che soffrono per un lavoro così inutile”, diceva nel 1922 quel lama tibetano del monastero di Rongbuk al passaggio di Mallory per l’Everest; più o meno quello che pensava il nostro buon curato di Vieyes incontrando, nel 1858, Lady Cole diretta alla Grivola), ma di sicuro ci sono eroi celebrati nei libri di storia che hanno fatto cose ben più dannose. Come quei ragazzi che partivano volontari per la guerra.
Alla fin fine, dallo studio dei materiali alla medicina, anche le imprese più estreme hanno dato il loro contributo alla scienza (altrimenti non troverebbero sponsor). E, almeno in qualche caso, non sono proprio una “conquista dell’inutile”, come avrebbe detto Lionel Terray. Basti pensare a cosa sta facendo Nirmal Purja per gli sherpa nepalesi o, proprio in questi giorni sull’Everest, Andrea Lanfri.
Il problema è semmai l’immaginario dell’alpinismo, ancora troppo legato al racconto dell’impresa, al gesto eroico, alle classifiche dei più bravi, alle polemiche su chi è arrivato primo. Generando l’idea che l’alpinismo sia solo quello e che “te la vai a cercare”. Purtroppo storici e giornalisti hanno qualche responsabilità in questa cosa, perché continuano a raccontare la storia dell’alpinismo come si faceva la storia una volta: una sequenza di re, condottieri, battaglie, grandi imprese. L’histoire événementielle la chiamavano i francesi. Finché qualcuno incominciò a chiedersi chi era il cuoco di Cesare o fece notare che nella Francia del Seicento non c’era soltanto Luigi XIV, ma anche venti milioni di francesi. E nacque la “storia sociale”.
Nella storia dell’alpinismo (come vedremo meglio nella quinta stagione di queste “Vie nuove”) non è ancora successo nulla del genere. Si continua a raccontare di imprese straordinarie anziché del come e del perché gli uomini vanno in montagna. Non si è ancora affermata una “storia sociale dell’alpinismo”, una storia che ci racconti non tanto chi è arrivato per primo su questa o quella montagna, chi ha aperto quella o quell’altra via, con quanti chiodi e quanto ossigeno, e chi è l’alpinista più forte, più veloce, più creativo. Ma ci racconti la normalità di chi va in montagna, correndo rischi tutto sommato accettabili.
Certo nessuno pensa a una storia dell’alpinismo senza Comici, Cassin, Bonatti e Messner, ma vorremmo anche una storia che ci racconti delle milioni di persone che in un certo momento incominciano ad andare in montagna, e poi magari smettono e incominciano ad arrampicare in palestra o sui sassi. Una storia che si interroghi sulle pratiche comuni, ma anche sui miti, sui significati simbolici, sugli usi politici della montagna. Sul perché, ad esempio, i tedeschi negli Trenta vanno a cercare la morte sulla nord dell’Eiger o sul Nanga Parbat, diventando eroi nazionali, o i polacchi negli anni Ottanta si gettano sugli ottomila d’inverno. Se cambiamo prospettiva e guardiamo a una storia sociale dell’alpinismo, potremmo scoprire che l’abbé Gorret o Pier Giorgio Frassati possono essere importanti quanto Edward Whymper o Emilio Comici. Che il nostro alpinisme à l’eau de rose (volete chiamarlo solo escursionismo? trekking? va bene) è stato un fenomeno importante e soprattutto sta ritornando di attualità.
Perché il problema di fondo, il vero nemico della montagna “maestra di vita”, è la desacralizzazione della montagna che abbiamo vissuto nel corso del Novecento. Non da parte degli alpinisti estremi che in fondo della montagna hanno un grandissimo rispetto (semmai si potrebbe discutere delle spedizioni commerciali che hanno trasformato l’Everest in un circo per dilettanti facoltosi), ma dai motori, dall’asfalto, dalle funivie, dalle “stazioni integrate” del turismo di massa che hanno capovolto la montagna, cancellato la fatica, trasformato uno spazio “sacro”, un luogo dello spirito, della meditazione e del silenzio, in un parco divertimenti.
Per questo la storia dell’alpinismo cattolico (ma potrebbe essere anche quella dell’escursionismo laico) non è soltanto una “storia del vecchio mondo”, una curiosità per eruditi o nostalgici. È una “via nuova” che si sposa con le più moderne politiche della montagna, con la Convenzione delle Alpi, con la ricerca di quella “terza via” di cui ci parlava Camanni vent’anni fa (e di recente in questa rubrica).
Quello che oggi chiamiamo “turismo dolce”, le “sweet mountains”, non sono altro che “l’alpinismo educatore” dell’abbé Gorret, gli “itinerari pacifici” della Giovane Montagna. Lo sono i “Cammini”, i “Sentieri”, dove si gioca il futuro del turismo alpino. Una montagna per tutti che non voglia dire asfalto e impianti di risalita, ma nemmeno una wilderness che condanni i montanari alla miseria.
Per questo ci servono ancora le pagine dell’abbé Gorret, le riflessioni della “Giovane Montagna”. Ci servirebbero ancora gli oratori e i preti che portano i ragazzi in montagna (perché i laici in Italia non hanno saputo fare altrettanto? Perché la sinistra non c’era?).
Talvolta le “Antiche Vie” possono rivelarsi delle “Vie Nuove” e forse è per questo che, di tanto in tanto, serve ancora la storia.
(Finale di stagione)
