Perché lassù? 5. “Gli eroi son tutti giovani e belli”
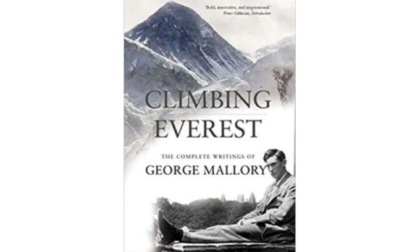
Perché lassù? 5. “Gli eroi son tutti giovani e belli”
Accadde qualcosa negli anni Venti del Novecento che ha cambiato le regole del gioco e l’immaginario dell’alpinista. Gli eroi, com’è noto, non esistono in sé, sono costruzioni sociali. Lo stesso comportamento (partire volontario per la guerra, ritirarsi a digiunare nel deserto o arrampicare in free solo su una verticale di mille metri), può essere folle od eroico a seconda dei luoghi e dei tempi. Se oggi un uomo di fede scegliesse di vivere in cima a una colonna, alla maniera di Simeone lo Stilita, difficilmente troverebbe moltitudini di fedeli pronti a santificarlo. E se oggi uno studente mi confessasse di voler morire per la patria quantomeno preavviserei lo psicologo (e mi spiace per l’amico Guccini - noi cresciuti cantando “La locomotiva” - ma anche il suo eroe “giovane e bello lanciato contro a un treno di signori”, oggi assomiglia tanto a un terrorista islamico).
Nella cultura europea, a partire del Cinquecento, il modello dell’eroe non fu più l’eremita penitente o il cavaliere alla ricerca del Santo Graal. Fu l’esploratore. Anche se la maggior parte di loro erano persone umanamente poco raccomandabili (non vorrei mai avere a che fare con un Magellano o un Vasco De Gama, e anche con un Colombo starei molto attento a cosa dire), la loro trasfigurazione narrativa in eroi è stata una delle costruzioni letterarie più intense della modernità. Il racconto delle imprese di James Cook o David Livingstone, la ricerca di Eldorado o delle sorgenti del Nilo, hanno tenuto l’Europa con il fiato sospeso. Agli eroi-esploratori tutto era concesso: fama, donne, onori e ricchezza. Et pour cause, erano l’avanguardia della conquista europea del mondo, l’epica dell’Europa.
Poi, però, all’inizio del Novecento, la Terra aveva svelato i suoi ultimi misteri. Con la conquista dei Poli, tutta la superficie terrestre era stata esplorata. E gli inglesi, che avevano guidato per duecento anni l’esplorazione del mondo, avevano perso tutte le ultime battaglie: il Passaggio a nord-ovest, il Polo nord e, sul filo traguardo, il Polo sud, con la tragica morte di Robert Falcon Scott e dei suoi compagni.
All’Impero britannico, che controllava ancora i due terzi del mondo, ma la cui legittimità incominciava a essere messa in discussione, servivano nuovi eroi. Nuove terre da esplorare. La frontiera dell’avventura doveva spostarsi nell’unico posto della superficie terrestre dove piede umano non fosse mai giunto: le misteriose montagne dell’Himalaya.
Finita la Grande Guerra, che per quattro anni aveva fatto incetta di tutto l’eroismo disponibile al mondo, anestetizzando ogni altra domanda d’avventura, la cultura europea doveva costruire una nuova figura dell’eroe. Bisognava solo incrociare il personaggio perfetto con la montagna perfetta.
George Mallory era giovane, bello, colto. Professore, giornalista, scrittore. Uomo affascinante, ufficiale di artiglieria, amato da uomini e donne; una bellissima moglie, tre bambini. Una solida preparazione alpinistica.
L’Everest, il “tetto del mondo”, la “dea madre”, “incalpestata terra”, sorgeva al confine tra due regni misteriosi e proibiti, il Nepal e il Tibet, alle lontane frontiere dell’Impero britannico. Due fogli ancora bianchi nelle carte geografiche del mondo dove l’immaginazione occidentale poteva proiettare tutte le sue fantasie sull’Oriente.
Il 10 gennaio 1921 la Royal Geographical Society comunicò l’intenzione di inviare una spedizione di alpinisti inglesi alla conquista dell’Everest. Il cavaliere incaricato dell’impresa fu George Mallory.
Respinto per due volte dalla montagna impossibile, Mallory volle ritornarci ancora, pur avendo un chiaro presentimento. Il suo ultimo gesto, prima di imbarcarsi per l’India, fu la visita a Kathleen, la moglie del grande e sfortunato esploratore polare, Robert Scott. La sua casa era un museo di ricordi: lettere, oggetti, fotografie dall’Antartide, custodite dalla vedova e dai giovani orfani.
Mallory e il suo compagno, Andrew Irvine, atletico studente di Oxford, campione di canottaggio, ma non troppo esperto di alpinismo, furono visti per l’ultima volta l’8 giugno 1924, al colle nord, mentre salivano verso la vetta. Poi la nebbia li avvolse. Per sempre.
E Mallory divenne un mito. In Inghilterra fu lutto nazionale. Per il Times “non avrebbero potuto scegliere una fine migliore”. Per gli amici dell’Alpine Club “ora non invecchieranno mai e non vorrebbero prendere il posto di nessuno di noi”. Francis Younghusband, presidente della Royal Geographical Society, alpinista di valore e promotore delle spedizioni himalayane, non aveva dubbi: Mallory aveva consapevolmente scelto di morire. Non poteva tornare sconfitto per la terza volta.
L’archetipo narrativo era pronto: andare avanti, oltre il punto di non ritorno, fino alla morte o alla gloria, ma non al fallimento. Ancor meglio se l’eroe svaniva nel nulla, quasi un’ascensione al cielo. Meglio senza sapere se diretto alla vetta e sulla via del ritorno, dopo aver calpestato per primo il tetto del mondo.
Solo la madre di Irvine non si unisce al coro e per anni tiene una luce accesa sulla veranda per indicare al figlio, nella notte, la strada di casa.
Difficile, negli anni a seguire, sfuggire al nuovo canone narrativo. Non lo farà la gioventù nazista, impegnata sulle “montagne assassine”, il Narga Parbat e la parete nord dell’Eiger, all’indomani dell’ascesa al potere di Hitler. Né “l’alpinismo eroico” italiano degli anni Trenta, celebrato da Rudatis e da Varale, impegnato nella conquista del sesto grado, in funzione della creazione fascista dell’uomo nuovo.
Un mito che andrà ben oltre l’uso propagandistico dei regimi nazionalistici degli anni Trenta. John F. Kennedy, in uno dei discorsi più famosi della sua presidenza, settembre 1962, stadio di Houston, Texas, annunciava il più ambizioso dei suoi programmi: portare un uomo sulla luna. «Perché la luna? perché scalare la montagna più alta? Molti anni fa - concludeva JFK - chiesero al grande esploratore britannico George Mallory perché volesse scalare l’Everest. “Perché è lì”, fu la risposta. Ebbene anche lo spazio è lì e noi lo scaleremo».
La corsa allo spazio non si rivelerà però un mito altrettanto efficace: troppo tecnologico, troppo poco umano. Dopo Amstrong fu la noia. Ci volle un Apollo 13 per farci un film. Anche l’esplorazione dei fondali marini non ha creato eroi. Troppa tecnologia, troppo buio, troppi controlli, troppi bottoni da schiacciare. Alle grandi narrazioni servono la carne ed il sangue, gli scenari grandiosi, non i cunicoli degli speleologi, le tastiere luminose o i lunghi silenzi dello spazio. E la montagna rimane la scenografia d’eccellenza, ma a un patto crudele: spostare sempre più in là i limiti del possibile.
… (continua)
